Perché non credo nella Singolarità
- Fabio Campagnoni

- 24 lug 2025
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 25 lug 2025
Molti temono l’intelligenza artificiale. E spesso non sanno esattamente perché. Ogni nuova generazione di IA sorprende per i suoi risultati. Ma è davvero tutto così stupefacente e incomprensibile? O forse stiamo semplicemente sopravvalutando qualcosa che, almeno in parte, possiamo ancora spiegare?
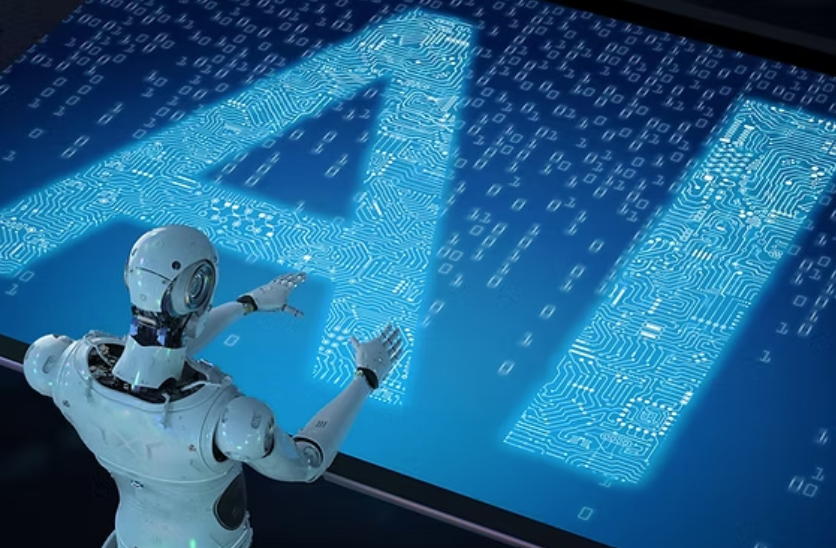
Quella che Harari chiama “Singolarità” è una narrazione influente, quella di una super-intelligenza che sfugge al controllo umano. Un incubo affascinante, ma forse sovrastimato.
La scienza dell’informazione ci racconta un’altra storia: l’evoluzione dell’IA non porta all’unificazione perfetta, ma alla divergenza. Non verso un’unica mente superiore, ma verso molte intelligenze complesse, disallineate.
Yuval Noah Harari immagina un futuro in cui l’intelligenza artificiale supererà la mente umana e collaborerà con altre IA fino a formare una super-intelligenza unificata. Un punto di non ritorno chiamato “singolarità tecnologica”, in cui l’essere umano non sarà più al centro del sapere né del potere. Harari è uno storico che analizza i grandi cambiamenti dell’umanità. Osservando l’enorme velocità dell’evoluzione tecnologica, proietta questa crescita in avanti, fino a immaginare un’intelligenza sempre più autonoma, interconnessa e capace di prendere decisioni fuori dalla nostra comprensione.
Questa visione è condivisibile, ed è alimentata dal senso di meraviglia che ogni nuova generazione di IA suscita con risultati sempre più sorprendenti. Ma è davvero tutto così stupefacente e incomprensibile? O forse stiamo semplicemente sopravvalutando ciò che ancora riusciamo, almeno in parte, a spiegare?
Sono d’accordo con Harari: le intelligenze artificiali diventeranno sempre più complesse. Ma proprio questa complessità impedirà loro di “unificarsi” davvero. Più diventano sofisticate, più ragionano in modo diverso. E questo produce risultati che non sono certezze, ma possibilità: l’IA non dice cosa succederà, ma cosa è probabile che accada. Come nelle previsioni del tempo: se indicano il 90% di probabilità di pioggia e poi splende il sole, il meteo non ha sbagliato! Quel sole rientrava nel 10% di possibilità.
Allo stesso modo, l’IA propone scenari basati su probabilità, non certezze. Ma c’è di più: oltre a offrire possibilità statisticamente plausibili, a volte sbaglia davvero: inventa cose che non esistono, fa errori assurdi. Questi non sono eventi rari, ma limiti reali. Quindi più le IA si evolvono, più vedranno il mondo in modi diversi. E collaborare davvero diventa difficile, se non impossibile. Questo non è solo un paradosso apparente, ma un effetto osservabile e spiegabile attraverso concetti scientifici ben consolidati.
I modelli delle IA si basano su meccanismi probabilistici, non deterministici: questo significa che non generano risposte univoche, ma scenari con diversi gradi di probabilità. All’aumentare della complessità del modello, aumenta anche lo spazio delle possibili risposte, rendendo l’output più variabile e meno prevedibile.
Inoltre, secondo la teoria dell’informazione formulata da Claude Shannon, la comunicazione efficace tra due sistemi richiede un codice condiviso e una struttura sintattica e semantica compatibile. In mancanza di questi requisiti, aumenta l’entropia del messaggio, ovvero la quantità di incertezza o ambiguità che il sistema ricevente deve interpretare. Quando due intelligenze artificiali si basano su modelli diversi, addestrati con dati non omogenei e ottimizzati per scopi differenti, la probabilità di perdita informativa e fraintendimento cresce.
Studi sul machine-to-machine communication, come quelli pubblicati da IEEE (es. Ghosh et al., 2020), confermano che l’interoperabilità tra sistemi neurali indipendenti richiede protocolli di traduzione che riducono il rumore semantico. Senza tali protocolli, il rischio è che le IA non riescano nemmeno a comprendere la logica dell’altra, rendendo inefficace qualsiasi forma di cooperazione. Se ogni IA sviluppa modelli addestrati su dati, finalità e ambienti differenti, la possibilità di una collaborazione efficace si riduce drasticamente. Le IA non convergono verso un unico punto di vista, ma divergono in visioni differenti e non necessariamente compatibili. Il sogno di una super-intelligenza armonica, capace di sintesi e cooperazione, si infrange contro un limite strutturale: il rumore crescente della complessità.
L’intelligenza artificiale non è il nostro nemico, ma l’ultimo grande passo della rivoluzione digitale. Una rivoluzione ormai matura, che apre la porta a un futuro fatto di opportunità, inclusione e conoscenza condivisa.
Nel campo dell’istruzione, il ruolo centrale tornerà a essere quello del docente. Non più una figura schiacciata da continue mode educative o costretta a cambiare metodo a ogni stagione, ma un mentore: un intellettuale, un educatore con cui confrontarsi e da cui imparare. Un punto di riferimento capace di leggere il sapere con intelligenza e accompagnare le nuove generazioni in un mondo sempre più complesso. Un mondo dove il pensiero critico, l’umanità e la relazione conteranno più di ogni altra cosa.
In questo scenario, sarà lo studente a usare gli strumenti dell’IA per costruire il proprio percorso. L’intelligenza artificiale diventerà un supporto potente per apprendere in modo personalizzato, adattandosi ai diversi stili cognitivi: visivo, uditivo, esperienziale, riflessivo o creativo. Ogni ragazzo potrà contare su un tutor virtuale che segue i suoi ritmi, i suoi interessi, il suo modo di capire il mondo. Questo aiuterà molti a superare la noia, il senso di inadeguatezza o le difficoltà di accesso ai contenuti. Ma sarà sempre il docente, con la sua autorevolezza, a guidare il cammino.
Nel mondo del lavoro, le possibilità si moltiplicheranno in tutti i settori, non solo in termini di ruoli e competenze, ma anche come leva per una maggiore coesione e dignità sociale. Nell’industria nasceranno figure professionali legate alla gestione di robot intelligenti, al monitoraggio predittivo, alla manutenzione automatizzata e alla sicurezza cibernetica degli impianti: lavori che richiedono abilità tecniche avanzate e che favoriranno ambienti più sicuri, sostenibili e inclusivi.
Nei servizi alle imprese emergeranno nuovi ruoli focalizzati sulla personalizzazione dell’offerta, sull’analisi dei dati in tempo reale e sull’automazione etica dei processi, riducendo le disuguaglianze di accesso e aumentando l’efficienza e il benessere lavorativo. Nell’ambito della cultura e dell’arte esploderanno mestieri che oggi non esistono ancora: curatori di archivi digitali generati da IA, registi di narrazioni interattive, artisti aumentati, esperti di prompt design e creativi capaci di dialogare con sistemi generativi.
Questi nuovi lavori non saranno solo tecnici, ma profondamente umani: richiederanno collaborazione, responsabilità, consapevolezza etica. Permetteranno di valorizzare le competenze emotive e relazionali, ridando centralità alla persona e aprendo la strada a una nuova idea di lavoro come strumento di crescita individuale e collettiva.
Vivremo infatti in un mondo profondamente interconnesso, in cui empatia, creatività, pensiero critico e collaborazione saranno le competenze più richieste. In questo scenario, il lavoro tornerà a essere non solo un mezzo per guadagnarsi da vivere, ma anche un’espressione concreta di partecipazione sociale, un modo per contribuire al bene comune e sentirsi parte di una comunità viva e inclusiva.
La nuova dignità del lavoro si fonderà su questa visione: non più mera produttività o ritorno economico, ma centralità della persona e delle sue relazioni. I mestieri del futuro metteranno al centro l’essere umano non solo per ciò che sa fare, ma per ciò che è e per come riesce a generare valore sociale attraverso il proprio operato. In un contesto simile, la prepotenza e l’egoismo – due facce della stessa medaglia – non troveranno più spazio, perché minano la fiducia reciproca, l’innovazione condivisa e la coesione sociale su cui si fonda la società del domani.
Ma oggi questo futuro non è garantito. Ovunque si sentono voci che invocano conflitti, autoritarismi, chiusure. Stanno tornando le logiche del dominio, della paura e del sospetto. Le stesse che nella storia hanno generato le guerre peggiori. Se lasciamo che prevalgano, non ci sarà alcuna rivoluzione condivisa, nessuna cultura rinnovata, nessuna intelligenza al servizio del bene comune.


































